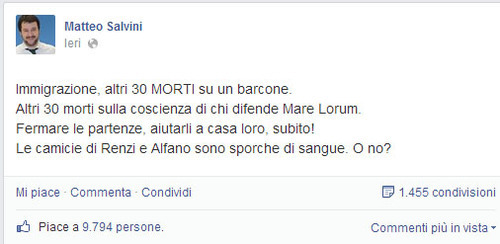La verità è nel mezzo. O meglio, ci vuole sempre tempo per dire la verità, per dire le cose come sono. E la maggior parte delle volte pur dicendo la verità, le cose come sono, si tratta sempre di un cenno di capo, un’indicare le cose come sono. In una parola: parlarne.
Per questo il giornalismo quotidiano è odiato dalla filosofia. Il giornale pretende di dire le cose come sono subito. Anzi il prima possibile, quasi prima che accadano, perché la notizia non aspetta, va data adesso. Proprio tutto il contrario della riflessione ponderata e attenta che arriva come una testuggine dritta dritta verso la verità.
È questa la spiegazione dietro la metafora della nottola di Minerva di Hegel. Il filosofo tedesco afferma: la nottola di Minerva spicca il suo volo sul far del crepuscolo. Significa: quello che è successo oggi lo capiamo (Minerva/Atena è la dea della saggezza simboleggiata da una civetta che vola) solo alla fine della giornata. È quello che fa lo storico, quello che fa il filosofo. La comprensione di ciò che è avviene soltanto quando ciò che è è stato. Prima che una cosa accade, come posso saperla? Non solo. Anche quando è accaduta, se non do il tempo al mio cervello di capirla come posso pretendere di capirla mentre accade? Al giornalismo tutto questo non piace. Al giornalismo quotidiano la civetta sta sulle scatole. Ma il giornalismo quotidiano si difende bene: non ha la presunzione di dirti la comprensione di quel che succede, ma solo quel che succede, la comprensione sarà una scelta successiva del lettore. Come quando ti capitano le cose senza che ancora non hai capito cosa sta succedendo. Ecco il giornalismo, io ti do quello che accade, senza comprensione. Pensate alle torri gemelle: sapevamo quello che stava succedendo quando accadeva e nei giorni immediatamente successivi? Ancora adesso non abbiamo capito del tutto cosa è successo, ma nel 2014 sappiamo molto più di quello che sapevamo nel 2001. La verità ha bisogno di tempo.
C’è una nuova guerra fredda in atto tra Stati Uniti e Russia, ma non è quella che vorrebbero i giornali con i loro titoli. Questa riproposta nei titoli dei giornali è la classica guerra fredda ante anni ‘90, quella fatta di ideologia politica e religioni, di apparati statali e capitali diversi. Ovvio che qualunque storico e filosofo inorridirebbe a questa sintesi arruffona, sempliciona e fuorviante, allarmista e sensazionalista. Un metodo non senza interesse questo del titolo strillato: il giornale quotidiano, oggi, strilla più di prima perché questo strillo è un urlo di agonia: “Leggetemi!”. Il giornale quotidiano non grida più la notizia ma la sua condizione di giornale quotidiano in crisi. Per questo parecchio giornalismo quotidiano di oggi non fa più giornalismo quotidiano, non ti dice più quello che accade ma scrive articoli che chiedono disperatamente di essere letti.
Ma questo non deve portare a odiare il giornalismo quotidiano, piuttosto la superficialità è la sua condanna e la sua esistenza una necessità. Si deve essere superficiali se si vuole dire quello che accade adesso senza saperlo. Il giornalismo quotidiano deve scegliere: o ti mostra quello che accade o ti dice la verità, ma a quel punto non è più giornalismo quotidiano ma inchiesta, storia, filosofia.

Ma non è vero neanche che non siamo di fronte a una nuova guerra fredda. Sarebbe altrettanto fuorviante anche un giudizio così. Un altro eccesso, un’altra semplificazione. È come quando si dice che non essendoci più la sinistra ci si deve accontentare di questo capitalismo, sforzandosi soltanto di renderlo più “etico” e “amichevole”, rendere più etica e amichevole questa economia mondiale basata sullo sfruttamento degli uomini e delle risorse.
Possiamo dire che c’è una nuova guerra fredda in atto senza per questo titolarla? Senza dire con questo la verità?
Si può dire che c’è una nuova guerra fredda, ma per capire che significa ci vuole tempo, non basta allacciarsi con un salto temporale a trent’anni fa, perché trent’anni son passati e non torneranno più.
È innegabile che l’oligarchia russa stia reagendo all’isolamento lento e inesorabile a cui era condannata. Gli Stati Uniti hanno vinto e preso tutto e la Russia semplicemente non ci sta più (proprio perché ne è passata acqua sotto i ponti da quando è caduto il Muro) ad accettare la persistenza americana fin quasi ai confini (ex) sovietici.
E allora di quale guerra fredda si tratta visto che non può più essere la guerra fredda (quella dei libri di storia)? Allora non dovrebbe chiamarsi più guerra fredda perché genererebbe confusione. Ma neanche ci si dovrebbe sforzare troppo a trovare un altro nome, perché qualcosa in comune con la vecchia guerra fredda questa guerra fredda di oggi dovrà averla, altrimenti correremmo lo stesso errore di considerare l’economia mondiale attuale un‘“altra economia”. La new economy, ricordate?
È una guerra, non c’è dubbio, perché ci sono i militari e la gente muore. È fredda perché non ci sono invasioni. Forse la differenza è nelle fazioni: non ci sono più due fazioni contrapposte, forse non ci sono proprio più fazioni. C’è prima di tutto un modello economico a cui aderiscono entrambe, a cui aderisce tutto il mondo. Così cade la differenza ideologica, l’ideologia politica alla base: Stati Uniti e Russia investono e accumulano profitti allo stesso modo, negli stessi posti, con le stesse persone. Tutto il mondo accumula, investe e fa profitto allo stesso modo e nello stesso luogo. È la globalizzazione baby!
Poi, essendosi sciolto il dualismo oppositivo ideologico e politico, sono fioriti tanti altri interessi particolari che prima venivano semplicemente soffocati dai due blocchi: prima del 1989 la parola Medio Oriente era un modo per dire petrolio, oggi è un modo per dire tantissime cose diverse.
La verità è allora che non c’è una sola guerra fredda, ma tante piccole guerre fredde.
La Russia reagisce come un cane che non vuole essere messo all’angolo. Un cane forte che vuole stabilire nuovi confini per aggiornare i punti strategici del gas e della geografia. Forse anche gli Stati Uniti reagiscono come un cane, più forte, ma sempre più messo all’angolo dalla moltitudine di stati che non può più controllare come in passato.
È sbagliato parlare di nuova guerra fredda, così com’è sbagliato dire che non si può più parlare di guerra fredda. La verità sta nel mezzo, e ancora non l’ho trovata.