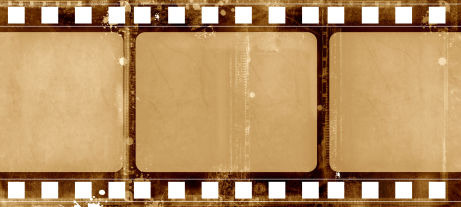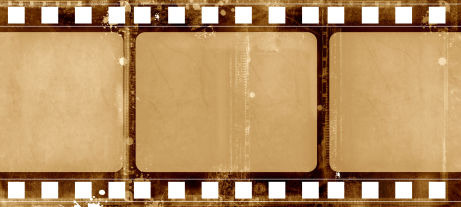
Uno dei motivi per cui adoro leggere Giorgio Agamben sta nel fatto che il filosofo italiano struttura i suoi discorsi (in particolare la serie degli Homo sacer) su una bibliografia che non potrò mai affrontare, quella religiosa. In più Agamben è un filosofo vivente e italiano: contemporaneità+lingua madre, che vuoi di più. Ma più di tutto, adoro leggere Agamben perché il professore amico di Morante e Pasolini (è Filippo ne Il Vangelo secondo Matteo), seminarista negli anni ‘60 dei corsi di Heidegger, mi avvicina all’eterogeneità degli studi. Agamben fa vibrare le mie corde di studioso di filosofia cresciuto a pane e storicismo confermandomi che per conoscere la modernità non basta abboffarsi di french theory ma bisogna accostare elementi eterogenei. Per esempio, conoscere un po’ di bibliografia monacale del XII e XIII secolo può essere molto istruttivo per illuminare il rapporto tra uomo e legge nel XXI secolo.
L’eterogeneità degli studi è il metodo che sceglie anche Tommaso Ariemma. Prolifico scrittore, napoletano, classe 1980, professore di estetica a Lecce, qualche mese fa ha pubblicato il suo ultimo libro, Sul filo del rasoio, Estetica e filosofia del taglio, confermando il fatto che in questi tempi aridi di riflessione ponderata e ricchi di attualità affrettata la cura del discorso è nell’eterogeneità degli studi. Come ogni filosofo che non si accontenta dell’accademia, in questo testo Tommaso si fa guidare da un’intuizione per applicarla all’attualità dei prodotti culturali odierni. In altre parole mette in atto quella che viene generalmente chiamata pop-filosofia, un modo come un altro per dire filosofia dopo la fine della filosofia. Filosofia come il tempo che resta tra l’annuncio della sua fine e la fine di questo vittimistico annuncio.
Un po’ come Agamben, fissato con la legge e la regola, Ariemma si è fissato ultimamente su un concetto in particolare, scoprendo come esso si annidi un po’ ovunque nelle cose, come ogni principio filosofico insegna. Questa intuizione è il taglio.
Per Ariemma, studioso di estetica, il taglio è fondamentalmente racconto, «un fatto primitivo» che si rivolge «a quel che di primitivo c’è in noi» (Edward Morgan Forster). Sul filo del rasoio non smette mai di raccontare: mette in scena autori, romanzi, film, aneddoti, tutti accomunati dalla loro capacità di tagliare. Rintraccia il taglio dove meno te l’aspetti, anche lì dove gli stessi autori non danno molta importanza al concetto, confermando la sentenza dell’ultimo filosofo: perdiamo sempre di vista l’essenziale. Deleuze, Benjamin, Agamben, Heidegger, Burroughs, Derrida, Eco, Hume, Hegel, Kojève, Lacan, Foucault, Sloterdijk, McLuhan, Platone, Žižek. E poi Blade Runner, il Batman di Nolan, Lost, le telenovelas, gli anime. Sul filo del rasoio li mette tutti insieme in un vortice incessante di ottanta pagine dove alla fine ciò che resta è il taglio. Ma di che taglio si tratta? L’assunto di base è che tutti questi autori adoperano tagli non allo scopo di separare, ma al contrario per mettere le cose in relazione. Il taglio come resto, propriamente: tagli le cose non per guardare nella fessura, piuttosto perché al contrario è il taglio l’unica cosa che ti resta quando vuoi accostare elementi eterogenei.
Com’è possibile che il taglio metta in relazione quando è proprio ciò che separa? Beh, la filosofia è sostanzialmente questo modo di ragionare, è essa stessa tagliata, bastarda, visto che per nascere si è dovuta tagliare in due: è prima poesia con i presocratici, poi discorso argomentato con Platone. Filosofia è lo stupore (thaumazein, θαυμάζειν) del mondo nello scoprire che per conoscere le cose che sono non ci si deve mai dimenticare delle apparenze. Platone litigava a morte con i sofisti, ma poi in fondo gli voleva bene. Sul filo del rasoio eredita questa concezione della filosofia ponendo il taglio come principio primo che sottende ogni conoscenza, ogni comprensione e ogni processo di relazione.
Ariemma pone due tesi sul taglio, seguendo la logica hegeliana in una squisita combinazione di dialettica e strutturalismo: nessun taglio si oppone alla relazione e non si dà taglio nell’opera che non sia anche simbolico. Due tesi che sembrano far dialogare le due epistemologie che hanno caratterizzato gli ultimi duecento anni di filosofia: la dialettica della Germania del XIX secolo e la struttura della Francia del XX.
Anziché soffermarmi ad analizzare le singole tesi, vorrei passare direttamente alla seconda, tanto ognuna richiama l’altra e alla fine verranno chiarite entrambe.
Che cos’è questo “simbolico” della seconda tesi, che persiste nonostante il taglio? Occorre una digressione.
Ariemma utilizza questa parola in un senso preciso. C’è un po’ di “uomo simbolico” di Cassirer, un po’ di struttura simbolica di Lévi-Strauss, e un po’ di altre cose che non mi vengono in mente, ma soprattutto c’è dietro il concetto di simbolico di un furbacchione che ha fatto man bassa dell’eredità filosofica a cavallo del XIX e XX secolo per fare del simbolo un concetto originale. Stiamo parlando dello psicoanalista francese Jacques Lacan.
Simbolico per Lacan è la denotazione di senso. Dal sorgere del sole che ti dice che la notte è finita all’interlocutore che ti parla, simbolico è una struttura insieme esosomatica e somatica: non ti appartiene, ma te ne appropri. Simbolico denota l’uomo non solo come essere parlante ma come quell’essere che non può mai smettere di parlare, nel senso di indicare, riferire, denotare, significare, distribuire senso, perfino quando è solo un corpo morto.

Dov’è la realtà in questa struttura? Semplicemente non c’è, è tagliata fuori. Lacan sostiene che è inutile porsi la domanda sul senso della realtà al di fuori della struttura del senso, del linguaggio, del simbolico, perché ogni volta che ci proviamo a tornarci indietro è sempre il senso, non la cosa in sé; il significante, non il significato; gli occhiali di Kant, non il veduto; la bottiglia di Wittgenstein, non ciò che c’è fuori. In altre parole, guardiamo sempre il dito, mai la luna. La realtà diventa così reale, si sostantivizza: il reale, compatto come un pianeta, impenetrabile, con la sua superficie tagliata dal simbolico. Così, il taglio che opera ogni discorso filosofico, ovvero quel discorso che vuole andare al fondo delle cose non accontentandosi della superficie, in realtà è sempre in superficie. Ariemma si muove parallelo a questa consapevolezza strutturalista affermando con prudenza che il taglio è anche simbolico (rispetto al reale). Lacan lo rimproverebbe con un sempre.
Il concetto di taglio di Ariemma aiuta a comprendere visivamente, esteticamente, il concetto di reale di Lacan. Il reale, afferma lo psicoanalista, è senza fessure, quindi senza tagli. Che significa? Significa che la denotazione di senso è sempre un’operazione di taglio, lì dove il reale è qualcosa che non si può tagliare, appunto senza fessure: non si dà taglio nell’opera che non sia anche simbolico. L’uomo non è semplicemente immerso nel senso, è piuttosto esso stesso questo senso (ecco, sto parlando come Derrida). Non smettiamo mai di parlare e di fraintenderci, sarebbe bello se un giorno ci si intendesse al volo, se si potesse vivere nel reale, rompere la tela del simbolico e approdare alla Luna, all’oggetto, alla cosa in sé. Ebbene, un mondo del genere, afferma Lacan, sarebbe la cosa più terribile che ci possa capitare. È il mondo dello psicotico in cui il simbolico si liquefa e la realtà si destruttura come reale. Lacan va oltre la gabbia del senso, trasforma la stanza del linguaggio nel quale l’essere abita in una sala degli specchi: il simbolico è proprio ciò che fa di un uomo un uomo, non c’è altro, e il velo di Maya andasse a quel paese.
Simbolico, direbbe Ariemma, è sostanzialmente un taglio sulla realtà, e all’uomo non interessa guardare attraverso la fessura, piuttosto preferisce il contorno. Per questo il taglio mette in relazione: se non ti interessa il buco, da cui non uscirà mai niente di sensato, allora ti deve interessare ciò che sta attorno.
Gli orifizi del corpo sono tagli, fessure attraverso cui passano cose. D’altro canto, una delle più eleganti definizioni di vita è esattamente questa fessura: la vita è l’oggetto da cui costantemente entra ed esce qualcosa, nel respiro, nel mangiare, nel parlare. La vita comincia con un taglio, afferma Ariemma nell’introduzione di Sul filo del rasoio. Il corpo è ciò che è fatto di tagli. Allora, la domanda che si pose Lacan in un pomeriggio di Primavera del 1965 non è poi così stramba: perché i pianeti non parlano? Perché non hanno fessure. Come il reale, sono sfere perfette, mentre l’uomo è pieno di tagli e buchi, per cui ha nella sua struttura il desiderio come mancanza.
Se la relazione che determina il taglio è nel contorno, non è tanto il taglio in sé a interessare Ariemma, quanto una certa articolazione che determina il taglio. Il titolo del suo lavoro è rivelatore: il filo del rasoio come luogo in cui articolare il taglio. L’artista, il chirurgo, lo scrittore, sono tutti accomunati da una capacità di fare del gesto pittorico, dell’operazione sul corpo, della scrittura una fessura su cui, intorno a cui, piuttosto che in cui, conoscere e interpretare il mondo. Questo, afferma Ariemma, esprime Fontana nei suoi quadri.
«Piuttosto che significare qualcosa di antipittorico, i celebri tagli di Lucio Fontana direbbero allora di qualcosa che accade, a fior di tela, su tutti i dipinti»
T. Ariemma, op. cit., p. 26.
Per Ariemma il taglio è nel dettaglio. L’inezia determina l’insieme e l’incompletezza fa di un oggetto un soggetto. Quando l’uomo ha scoperto l’inconscio, ha scoperto sì di non essere padrone a casa propria, ma soprattutto che questa casa dell’essere in cui vive è senza proprietario, è linguaggio esosomatico che non gli appartiene, pur restando una struttura di cui si può appropriare. In pratica la casa dell’essere è un usucapione.
Ad Ariemma però non interessa l’analisi linguistico-strutturalista con le sue conseguenze ontologiche. È un prof di estetica, per cui dice più semplicemente e acutamente che questo soggetto come ciò che è tagliato è la soglia che articola un certo modo di fare arte, quella del montaggio. Ariemma porta all’esempio il finale di Blade Runner che, troppo cupo, viene tagliato con scene dallo Shining di Kubrick; la serie tv Lost con quelle storie piene di buchi che riempiono la sceneggiatura e caricano di aspettative gli spettatori. Tagli che riempiono più che separare. Ancora, la serie tv I Sopranos, con quella narrazione “cattiva” e umana che ha ispirato i vari The Wire e Breaking Bad. Per Ariemma tutte queste produzioni non sono nient’altro che storie determinate da tagli in cui ci identifichiamo. Jimmy McNulty è un abilissimo detective fedifrago, Walter White uno spietato padre di famiglia. Contraddizioni che si sciolgono nell’oscura fessura di un taglio narrativo che dona realismo.
Chi è stato il primo a mettere in scena questo soggetto tagliato, che manca a sé stesso (manque à être) come direbbe Lacan. Sul filo del rasoio non ha alcun dubbio: è il romanziere d’appendice inglese Charles Dickens. Secondo Ariemma parte della cinematografia e della televisione attuale deve molto al romanziere di Portsmouth. Il regista inglese Christopher Nolan si è ispirato a Dickens nella sua trilogia di Batman e la serie House of Cards lo cita esplicitamente «alla fine del decimo episodio della seconda stagione, citando l’incipit di Storia di due città» racconta Ariemma. Dickens, spiega Sul filo del rasoio, è stato il primo a raccontare il soggetto tagliato tagliando a pezzetti la sua storia, il primo a raccontare storie che mettono al centro il personaggio più che la trama, o meglio storie in cui la trama emerge dal taglio narrativo dato al personaggio.
«Ciò che fa la sua comparsa in Dickens e nel suo successo è una soggettività pensata all’interno di una dinamica di possessione, possessione generata da tagli».
Ibid., p. 44.
L’uomo è posseduto dal simbolico, che si articola tramite tagli.
È un errore, afferma Ariemma, insistere su ciò che ci possa essere dietro il taglio, nello spazio vuoto della fessura, nel buco dietro la tela di Fontana. In realtà è tutto già qui, nel contorno, in una superficie già piena zeppa di tagli. Giocare col reale di Lacan come fosse un Impossibile, un iperuranio a cui protendere, è la vera follia. Reale è al massimo un’idea regolativa, un noumeno di cui è inutile proprio porsi la questione dell’esistenza.

Un soggetto pensante sul filo del rasoio è quodilibet:
«La traduzione corrente nel senso di “non importa quale, indifferentemente” è certamente corretta, ma, quanto alla forma, dice esattamente il contrario del latino: quodlibet ens non è “l’essere, non importa quale”, ma “l’essere tale che comunque importa”; esso contiene, cioè, già sempre un rimando al desiderare (libet), l’essere qual-si-voglia è in relazione originale col desiderio».
Giorgio Agamben, La comunità che viene, Bollati Boringhieri, Torino 2001, p. 9.
Per questo il taglio mette in relazione, perché se lo guardiamo per quello che è vedremmo solo i contorni del taglio, dettagli, non buchi. Se l’essere è sempre un esser-tale, per riprendere il bellissimo libro di Agamben sopracitato, il reale, senza fessure, è la cosa senza -qual.
Così non esiste taglio reale, ogni taglio è sempre simbolico. O meglio, come afferma Ariemma in Sul filo del rasoio: «Tutti i tagli reali vengono compresi come tagli simbolici» (p. 27).
Il pilota di moto Valentino Rossi parla spesso di “un click nella testa” quando spiega la sensazione che si ha quando la moto diventa un prolungamento del tuo corpo, quando sai, in quel momento, che sei il più forte. Rossi non lo sa, ma si sta riferendo proprio alla relazione che determina il taglio concepito da Ariemma: l’eterogeneità di una relazione in cui un corpo biologico si fa tutt’uno con quello meccanico della moto, con i due oggetti che non si fondono, restano separati, propriamente: sono tagliati dalla relazione, esattamente come il corpo e il linguaggio. Ariemma spiega bene questa eterogeneità della relazione che pone il taglio citando Leroi-Gourham:
«È un processo globale che fa sì che, in un momento dato, l’utensile agisca come un prolungamento del corpo, ma vi è comunque una cesura che non può essere ignorata».
André Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, cit. in T. Maldonado, Memoria e conoscenza, Milano 2005, cit. in T. Ariemma, op. cit., p. 10.
La tecnica del taglio, quindi saper fare (téchne, τέχνη) il taglio al momento giusto, è ciò che rende uomo un uomo, che diventa così esso stesso una tecnica, un’antropotecnica direbbe Sloterdijk, un pilota di moto direbbe Rossi.
Filosofia è saper tagliare le cose, giustapporre senza mescolare, mantenere l’eterogeneità delle cose pur mettendole in relazione, come quando tagli la droga:
«Tagliare una droga significa diluirla, miscelandola a una sostanza di minor valore. Il taglio, pertanto, non separa ma aggiunge altre sostanze alla sostanza stupefacente».
T. Ariemma, op. cit.., p. 56.
Sul filo del rasoio si conclude con una specie di pamphlet, quando, staccandosi apparentemente dall’analisi estetica del taglio, sfocia in una proposta politica radicale. Lo fa con continuità, senza prorompere, sul filo del discorso intavolato in precedenza, appunto.
L’appello politico è che si faccia anche di questo taglio filosofico un buon uso nella società. Parafrasando il classico di Ernst Kantorowicz, I due corpi del re, Ariemma conclude sostenendo che non abbiamo ancora avuto il coraggio di dare un taglio al vero re, che non è quello fisico che ci comanda ma quello simbolico che ci tiene in scacco anche quando il re in carne e ossa è morto.
Dare un taglio al re allora non è limitarsi a soppiantare un re con un altro. Questo è il taglio che divarica e mantiene lo sguardo sul buco che ha creato, e si spaventa, quando invece abbiamo detto che è il contorno a contare. Bisogna insomma adoperarsi in un taglio che faccia sgorgare emancipazione.
Quale racconto può mettere in scena questo taglio rivoluzionario? Ancora una volta, Dickens:
«Dickens è di recente riscoperto e utilizzato quando si vuole ricercare il connubio tra complesso e popolare, ovvero quando si vuole che la narrazione sia magnetica, ma anche emancipatrice».
Ibid., p. 35.
Perché Dickens e non Balzac, Dumas? Perché Dickens racconta il logorio della classe operaia tagliando il confine tra alto e basso. Articola elitario e popolare in un personaggio buono e cattivo, realistico, che si riscatta riflettendo le aspirazioni degli spettatori. Non dimentichiamoci, ricorda Sul filo del rasoio, che tutte le intelligenze sono uguali.
Così, alle due tesi di Ariemma sul taglio se ne potrebbe aggiungere una terza: il taglio, quando è principio di relazione, è potenza emancipatrice.

Per Ariemma il fallimento della Rivoluzione Francese è consistito nel riempire lo squarcio che il taglio ha creato. Ci si è fissati sul buco, così il rivoluzionario taglio relazionale è diventato taglio di sottrazione e divaricazione. Il Terrore, afferma Ariemma, non è figlio della ghigliottina, semmai dell’ossessione di riempire i vuoti di potere che il taglio provoca, anziché lasciarli in pace.
«Si potrebbe parlare del Terrore giacobino come di quel momento in cui il taglio che iscrive in una società smette di proseguire sulla strada del simbolico e ritorna su quella del reale: torna a iscriversi sulla carne per marcare questa volta non l’inclusione, ma l’esclusione dall’ordine simbolico».
Ibid., p. 70.
È proprio questa ossessione per la sostituzione, per il potere, a determinare l’eterno ritorno della servitù volontaria e il rimando ad infinitum di una società senza classi. È questo che rende il comunismo una religione invece di una buona novella. Dobbiamo affezionarci al taglio, sostiene Ariemma, senza preoccuparci di riempire il vuoto che porta con sé. Il comunismo deve avere il coraggio di ereditare questa violenta relazione che determina il taglio se vuole sopravvivere all’assalto liberale, che ci riempe la bocca di rivoluzione senza rivoluzione, di pensiero debole e capitalismo etico e intanto anche lui non può smettere di tagliuzzare e separare un soggetto spolpandolo come in un tritacarne, quando un soggetto è per definizione già tagliato.